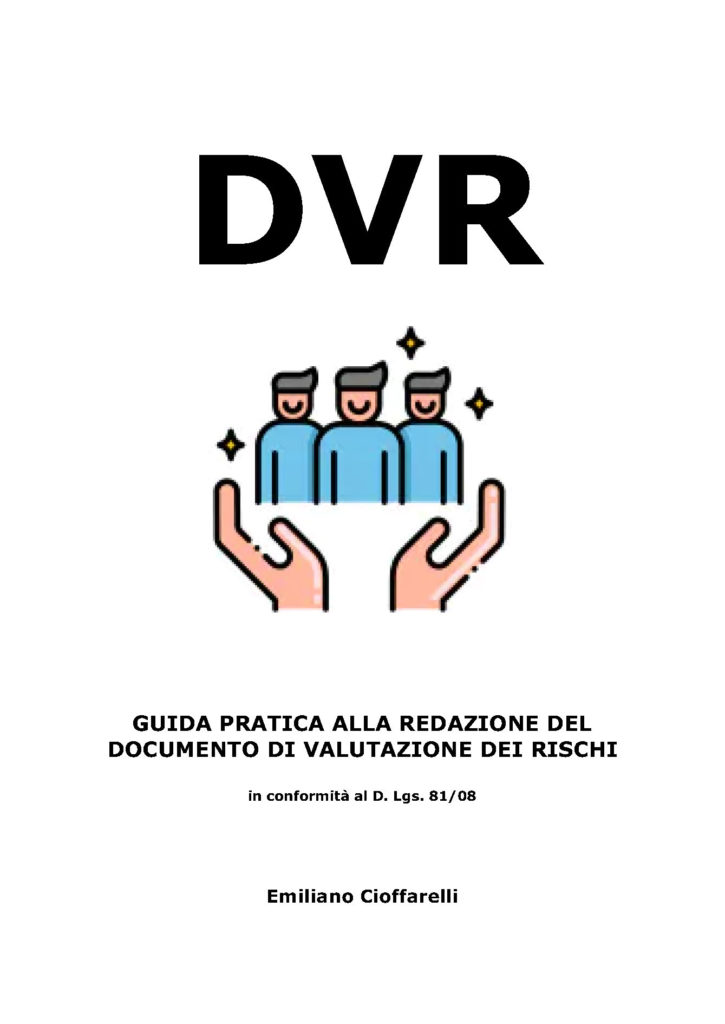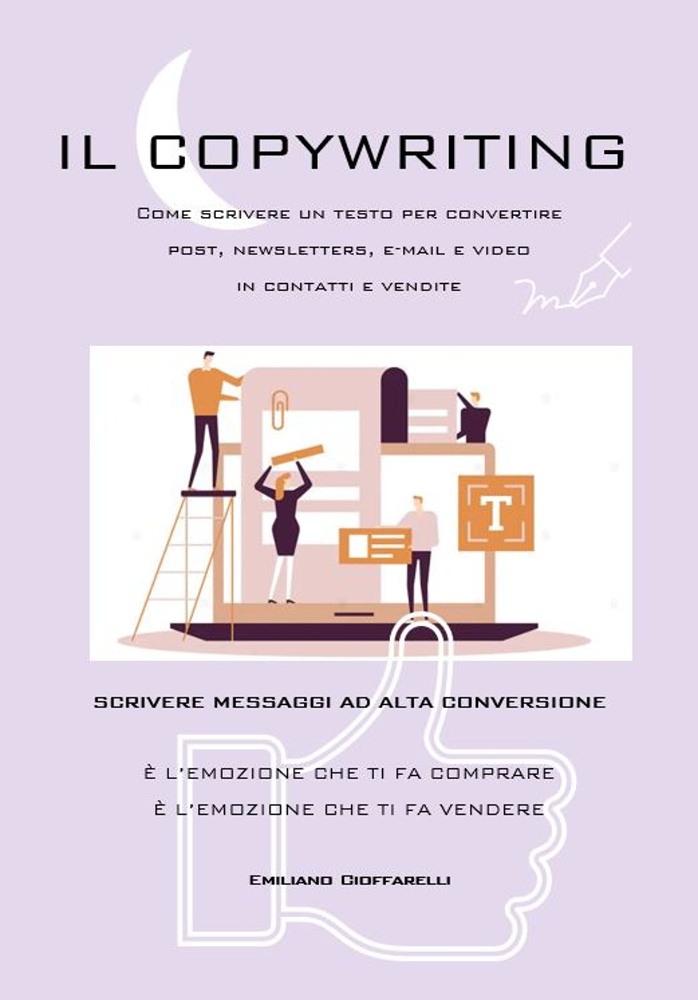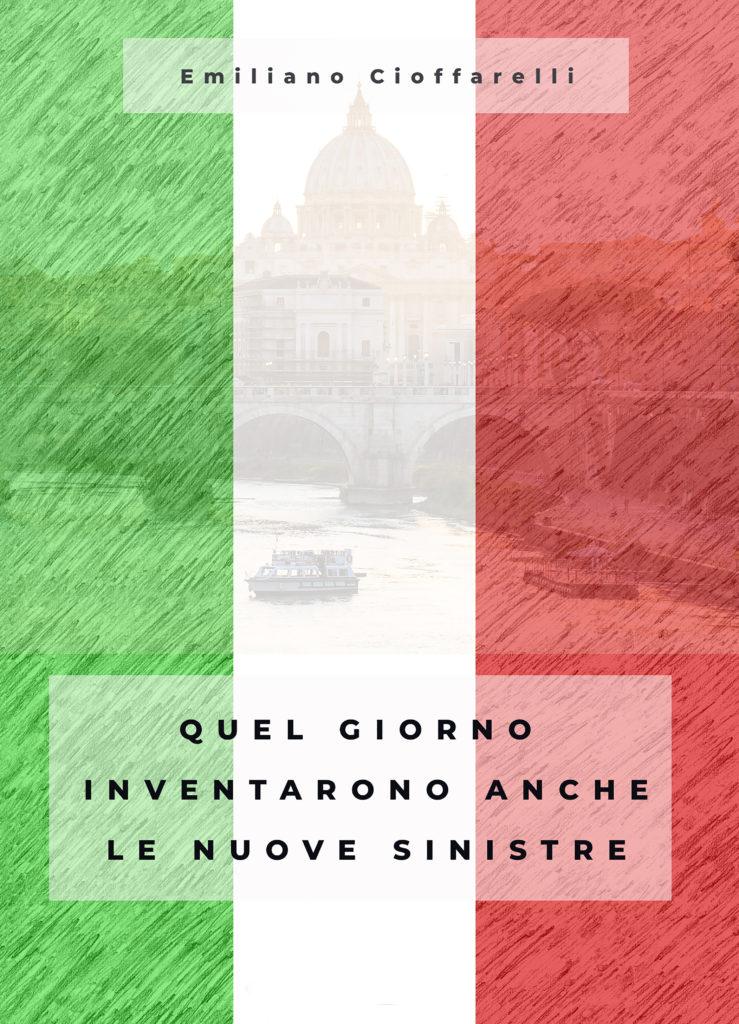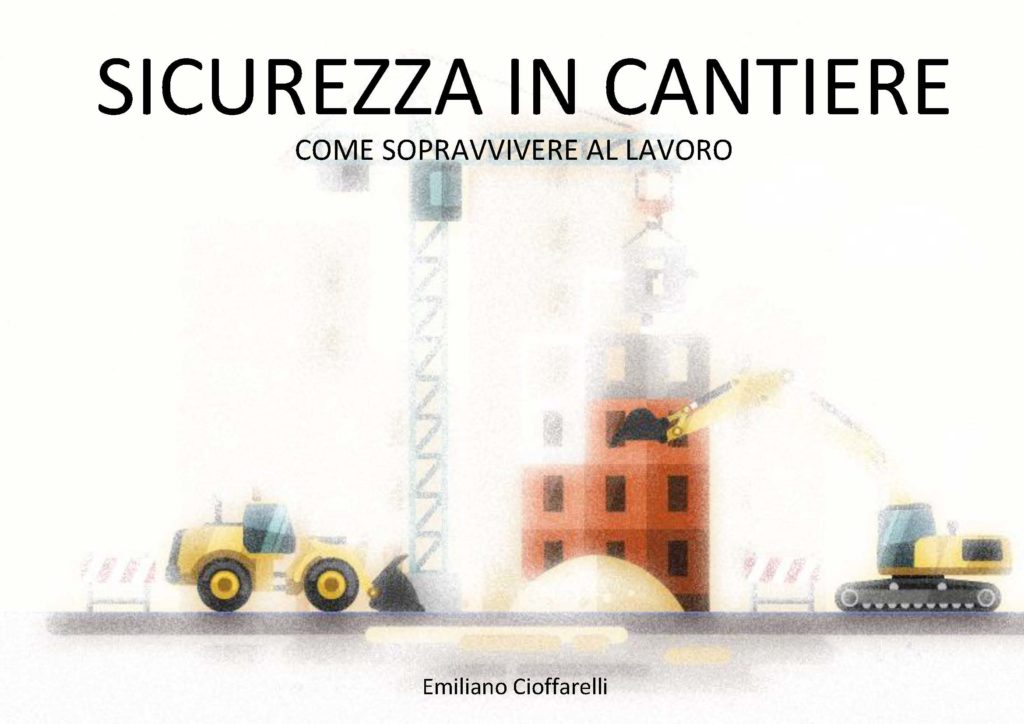La Montagna di Carte
Francesca si massaggia le tempie e guarda la pila di documenti sulla scrivania. DVR, POS, valutazioni dei rischi, registri di formazione. Tutto perfettamente ordinato. Tutto firmato. Tutto nel cassetto.
Si occupa di amministrare una piccola azienda di trasporti e, per lei, la sicurezza sul lavoro è sempre stata questo: un insieme di scartoffie da compilare e archiviare.
L’importante è avere tutto in regola in caso di controlli. Non è che non le importi dei suoi dipendenti, ma il lavoro è tanto e le giornate sono piene. Le normative sono complesse, sembrano fatte per rallentare tutto.
“Se i documenti sono a posto, siamo a posto,” si ripete ogni volta.
Poi squilla il telefono.
La sua voce si incastra in gola quando sente le parole dall’altro lato della linea.
“Francesca, vieni subito in officina. C’è stato un incidente.”
Corre. Il rumore delle scarpe che battono sul pavimento della rimessa si mescola alle voci concitate dei dipendenti.
Quando arriva, Matteo, uno dei meccanici più giovani, è seduto a terra. Ha una mano sul ginocchio, il volto teso. Accanto a lui, un paio di colleghi.
“Che è successo?” chiede Francesca, con il respiro ancora irregolare.
“È scivolato mentre scendeva dal camion,” dice uno dei ragazzi. “Il gradino era rotto.”
Il sangue le si gela nelle vene.
Matteo la guarda, abbozza un sorriso. “Non è niente di grave, solo una botta.”
Ma Francesca non riesce a distogliere lo sguardo da quel gradino. Lo stesso che, qualche settimana prima, Matteo aveva segnalato. Lo stesso che era finito in un report. Lo stesso che lei aveva letto, archiviato e dimenticato.
Non riesce più a respirare normalmente.
E se fosse stato più grave? Se Matteo avesse battuto la testa? Se fosse rimasto schiacciato sotto il camion?
La montagna di carte sulla sua scrivania non ha evitato nulla.
Per la prima volta, capisce che la sicurezza non è un fascicolo, ma una persona seduta a terra con un ginocchio gonfio e gli occhi pieni di fiducia malriposta.
Due giorni dopo, un ispettore entra nel suo ufficio.
Non è lì per l’incidente di Matteo, è un controllo di routine. Ma Francesca sente un nodo allo stomaco quando vede i documenti sparsi sulla scrivania.
L’ispettore sfoglia i fascicoli con attenzione. DVR, POS, valutazioni dei rischi. Tutto perfetto. Tutto classificato. Tutto… inutile.
“Quante ispezioni interne fate?” chiede l’ispettore, senza sollevare lo sguardo.
Francesca esita.
“Abbiamo tutta la documentazione in regola,” dice, cercando di mantenere il tono professionale.
L’ispettore chiude il fascicolo con un colpo secco. “Non è quello che ho chiesto.”
Silenzio.
“Quanti corsi di formazione pratica avete fatto nell’ultimo anno?”
Ancora silenzio.
L’ispettore la osserva per un lungo istante. Poi si alza, prende il suo taccuino e dice solo una frase prima di uscire:
“Signora, la sua azienda è perfetta sulla carta. Peccato che la sicurezza non sia solo un documento.”
La porta si chiude dietro di lui.
E Francesca sente il crollo.
Quella sera, a casa, apre il DVR e lo legge tutto d’un fiato.
C’è tutto: valutazioni di rischio, procedure, misure di prevenzione. Sulla carta, è inattaccabile.
Ma mentre scorre le pagine, qualcosa le sfugge di mano. La consapevolezza che le parole scritte non hanno mai impedito un incidente.
E allora si chiede: quante di queste misure vengono davvero applicate?
Il DVR parla di controlli periodici sui mezzi, ma quando sono stati fatti l’ultima volta?
Parla di riunioni sulla sicurezza. Ma l’ultima risale a due anni prima.
È tutto lì. Perfetto. Ma mai applicato.
E in quel momento, capisce.
Ha sempre visto la sicurezza come un obbligo normativo. Un costo. Una firma su un pezzo di carta.
E invece è Matteo che scivola.
È un gradino che non ha mai fatto riparare.
È il momento in cui tutto poteva andare storto.
E la colpa è sua.
Il giorno dopo, Francesca raduna tutti.
“Da oggi cambiamo tutto.”
Gli operai si guardano tra loro. Non è mai stata una che parla di sicurezza con così tanta convinzione.
“Non voglio più che la sicurezza sia solo un obbligo di legge. Voglio che sia il nostro modo di lavorare.”
Si avvicina al camion e indica il gradino riparato.
“Questo ha mandato Matteo a terra. E il problema non era il gradino. Il problema ero io, che non ho ascoltato.”
Si guarda intorno. Respira. Poi prende un’agenda e la apre.
“Ecco il piano: ispezioni settimanali su tutti i mezzi. Corsi di aggiornamento pratici, non solo teorici. Riunioni di sicurezza ogni mese.”
Si ferma. “E soprattutto: se qualcuno vede un problema, me lo dice subito.”
Silenzio.
Poi Matteo sorride. “Era ora.”
E Francesca, per la prima volta, sente che quelle parole hanno un peso reale.
Da quel giorno, la sicurezza smette di essere un documento e diventa un’azione.
Un mese dopo, Marco, il capo officina, entra nel suo ufficio con un report.
“Guarda questo,” dice.
Incidenti ridotti del 50%.
Francesca legge due volte. Poi sorride.
Alza lo sguardo verso la libreria.
Gli scaffali sono pieni di registri, certificazioni, DVR.
Tutti firmati. Tutti perfetti.
Ma adesso sa che non sono quelle carte ad aver evitato il prossimo incidente.
Sono stati gli operai che si sentono liberi di parlare.
Sono state le ispezioni fatte davvero, non solo sulla carta.
Sono state le decisioni prese prima che qualcuno si facesse male.
Ha perso anni a riempire documenti.
Ora sta imparando a proteggere persone.
E questa, finalmente, è sicurezza.
SCOPRI SAFE HOME: THE SAFETY PROJECT
#sicurezza #lavoro #lavoratori #81/08 #testounico #formazione #safehome